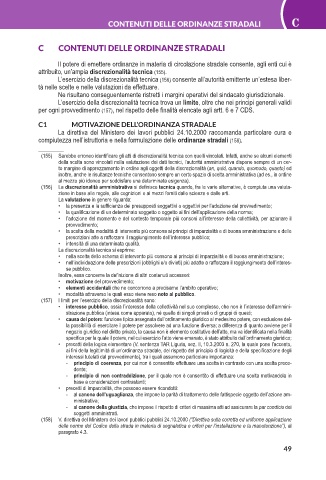Page 11 - Ordinanze stradali
P. 11
CONTENUTI DELLE ORDINANZE STRADALI C
C CONTENUTI DELLE ORDINANZE STRADALI
Il potere di emettere ordinanze in materia di circolazione stradale consente, agli enti cui è
attribuito, un’ampia discrezionalità tecnica (155).
L’esercizio della discrezionalità tecnica (156) consente all’autorità emittente un’estesa liber-
tà nelle scelte e nelle valutazioni da effettuare.
Ne risultano conseguentemente ristretti i margini operativi del sindacato giurisdizionale.
L’esercizio della discrezionalità tecnica trova un limite, oltre che nei principi generali validi
per ogni provvedimento (157), nel rispetto delle fi nalità elencate agli artt. 6 e 7 CDS.
C1 MOTIVAZIONE DELL’ORDINANZA STRADALE
La direttiva del Ministero dei lavori pubblici 24.10.2000 raccomanda particolare cura e
compiutezza nell’istruttoria e nella formulazione delle ordinanze stradali (158).
(155) Sarebbe erroneo identifi care gli atti di discrezionalità tecnica con quelli vincolati. Infatti, anche se alcuni elementi
della scelta sono vincolati nella valutazione dei dati tecnici, l’autorità amministrativa dispone sempre di un cer-
to margine di apprezzamento in ordine agli oggetti della discrezionalità (an, quid, quando, quomodo, quanto) ed
inoltre, anche le risultanze tecniche consentono sempre un certo spazio di scelta amministrativa (ad es., in ordine
al mezzo più idoneo per soddisfare una determinata esigenza).
(156) La discrezionalità amministrativa si defi nisce tecnica quando, fra le varie alternative, è compiuta una valuta-
zione in base alle regole, alle cognizioni e ai mezzi forniti dalle scienze e dalle arti.
La valutazione in genere riguarda:
• la presenza e la suffi cienza dei presupposti soggettivi o oggettivi per l’adozione del provvedimento;
• la qualifi cazione di un determinato soggetto o oggetto ai fi ni dell’applicazione della norma;
• l’adozione del momento e del contesto temporale più consoni all’interesse della collettività, per azionare il
provvedimento;
• la scelta della modalità di intervento più consona ai principi di imparzialità e di buona amministrazione e delle
prescrizioni atte a rafforzare il raggiungimento dell’interesse pubblico;
• intensità di una determinata qualità.
La discrezionalità tecnica si esprime:
• nella scelta dello schema di intervento più consono ai principi di imparzialità e di buona amministrazione;
• nell’individuazione delle prescrizioni (obblighi e/o divieti) più adatte a rafforzare il raggiungimento dell’interes-
se pubblico.
Inoltre, essa concerne la defi nizione di altri contenuti accessori:
• motivazione del provvedimento;
• elementi accidentali che ne concorrono a precisarne l’ambito operativo;
• modalità attraverso le quali esso viene reso noto al pubblico.
(157) I limiti per l’esercizio della discrezionalità sono:
• interesse pubblico, ossia l’interesse della collettività nel suo complesso, che non è l’interesse dell’ammini-
strazione pubblica (intesa come apparato), né quello di singoli privati o di gruppi di questi;
• causa del potere: funzione tipica assegnata dall’ordinamento giuridico al medesimo potere, con esclusione del-
la possibilità di esercitare il potere per assolvere ad una funzione diversa; a differenza di quanto avviene per il
negozio giuridico nel diritto privato, la causa non è elemento costitutivo dell’atto, ma va identifi cata nella fi nalità
specifi ca per la quale il potere, nel cui esercizio l’atto viene emanato, è stato attribuito dall’ordinamento giuridico;
• precetti della logica elementare (V. sentenza TAR Liguria, sez. II, 10.3.2003 n. 270, la quale pone l’accento,
ai fi ni della legittimità di un’ordinanza stradale, del rispetto del principio di logicità e della specifi cazione degli
interessi tutelati dal provvedimento), tra i quali assumono particolare importanza:
- principio di coerenza, per cui non è consentito effettuare una scelta in contrasto con una scelta prece-
dente;
- principio di non contraddizione, per il quale non è consentito di effettuare una scelta motivandola in
base a considerazioni contrastanti;
• precetti di imparzialità, che possono essere ricondotti:
- al canone dell’uguaglianza, che impone la parità di trattamento delle fattispecie oggetto dell’azione am-
ministrativa;
- al canone della giustizia, che impone il rispetto di criteri di massima atti ad assicurare la par condicio dei
soggetti amministrati.
(158) V. direttiva del Ministero dei lavori pubblici pubblici 24.10.2000 (“Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione
delle norme del Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”), al
paragrafo 4.3.
49