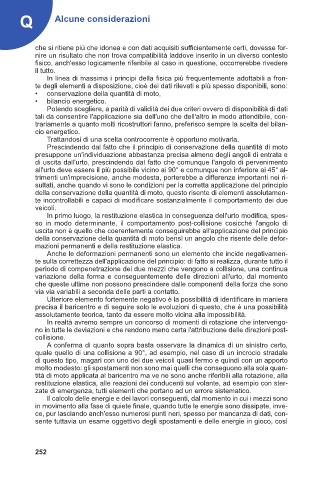Page 43 - Ricostruzione incidenti stradali
P. 43
Q Alcune considerazioni
che si ritiene più che idonea e con dati acquisiti suffi cientemente certi, dovesse for-
nire un risultato che non trova compatibilità laddove inserito in un diverso contesto
fi sico, anch'esso logicamente riferibile al caso in questione, occorrerebbe rivedere
il tutto.
In linea di massima i principi della fi sica più frequentemente adottabili a fron-
te degli elementi a disposizione, cioè dei dati rilevati e più spesso disponibili, sono:
• conservazione della quantità di moto,
• bilancio energetico.
Potendo scegliere, a parità di validità dei due criteri ovvero di disponibilità di dati
tali da consentire l'applicazione sia dell'uno che dell'altro in modo attendibile, con-
trariamente a quanto molti ricostruttori fanno, preferisco sempre la scelta del bilan-
cio energetico.
Trattandosi di una scelta controcorrente è opportuno motivarla.
Prescindendo dal fatto che il principio di conservazione della quantità di moto
presuppone un'individuazione abbastanza precisa almeno degli angoli di entrata e
di uscita dall'urto, prescindendo dal fatto che comunque l'angolo di pervenimento
all'urto deve essere il più possibile vicino ai 90° e comunque non inferiore ai 45° al-
trimenti un'imprecisione, anche modesta, porterebbe a diff erenze importanti nei ri-
sultati, anche quando vi sono le condizioni per la corretta applicazione del principio
della conservazione della quantità di moto, questo risente di elementi assolutamen-
te incontrollabili e capaci di modifi care sostanzialmente il comportamento dei due
veicoli.
In primo luogo, la restituzione elastica in conseguenza dell'urto modifi ca, spes-
so in modo determinante, il comportamento post-collisione cosicché l'angolo di
uscita non è quello che coerentemente conseguirebbe all'applicazione del principio
della conservazione della quantità di moto bensì un angolo che risente delle defor-
mazioni permanenti e della restituzione elastica.
Anche le deformazioni permanenti sono un elemento che incide negativamen-
te sulla correttezza dell'applicazione del principio: di fatto si realizza, durante tutto il
periodo di compenetrazione dei due mezzi che vengono a collisione, una continua
variazione della forma e conseguentemente delle direzioni all'urto, dal momento
che queste ultime non possono prescindere dalle componenti della forza che sono
via via variabili a seconda delle parti a contatto.
Ulteriore elemento fortemente negativo è la possibilità di identifi care in maniera
precisa il baricentro e di seguire solo le evoluzioni di questo, che è una possibilità
assolutamente teorica, tanto da essere molto vicina alla impossibilità.
In realtà avremo sempre un concorso di momenti di rotazione che intervengo-
no in tutte le deviazioni e che rendono meno certa l'attribuzione delle direzioni post-
collisione.
A conferma di quanto sopra basta osservare la dinamica di un sinistro certo,
quale quello di una collisione a 90°, ad esempio, nel caso di un incrocio stradale
di questo tipo, magari con uno dei due veicoli quasi fermo e quindi con un apporto
molto modesto: gli spostamenti non sono mai quelli che conseguono alla sola quan-
tità di moto applicata al baricentro ma ve ne sono anche riferibili alla rotazione, alla
restituzione elastica, alle reazioni dei conducenti sul volante, ad esempio con ster-
zate di emergenza, tutti elementi che portano ad un errore sistematico.
Il calcolo delle energie e dei lavori conseguenti, dal momento in cui i mezzi sono
in movimento alla fase di quiete fi nale, quando tutte le energie sono dissipate, inve-
ce, pur lasciando anch'esso numerosi punti neri, spesso per mancanza di dati, con-
sente tuttavia un esame oggettivo degli spostamenti e delle energie in gioco, così
252