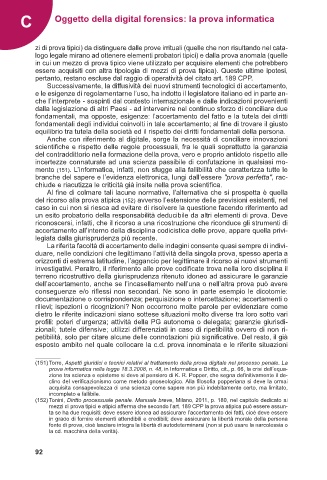Page 22 - Digital forensics
P. 22
C Oggetto della digital forensics: la prova informatica
zi di prova tipici) da distinguere dalle prove irrituali (quelle che non risultando nel cata-
logo legale mirano ad ottenere elementi probatori tipici) e dalla prova anomala (quelle
in cui un mezzo di prova tipico viene utilizzato per acquisire elementi che potrebbero
essere acquisiti con altra tipologia di mezzi di prova tipica). Queste ultime ipotesi,
pertanto, restano escluse dal raggio di operatività del citato art. 189 CPP.
Successivamente, la diff usività dei nuovi strumenti tecnologici di accertamento,
e le esigenze di regolamentarne l’uso, ha indotto il legislatore italiano ed in parte an-
che l’interprete - sospinti dal contesto internazionale e dalle indicazioni provenienti
dalla legislazione di altri Paesi - ad intervenire nel continuo sforzo di conciliare due
fondamentali, ma opposte, esigenze: l’accertamento del fatto e la tutela dei diritti
fondamentali degli individui coinvolti in tale accertamento; al fi ne di trovare il giusto
equilibrio tra tutela della società ed il rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Anche con riferimento al digitale, sorge la necessità di conciliare innovazioni
scientifi che e rispetto delle regole processuali, fra le quali soprattutto la garanzia
del contraddittorio nella formazione della prova, vero e proprio antidoto rispetto alle
incertezze connaturate ad una scienza passibile di confutazione in qualsiasi mo-
mento (151). L’informatica, infatti, non sfugge alla fallibilità che caratterizza tutte le
branche del sapere e l’evidenza elettronica, lungi dall’essere "prova perfetta", rac-
chiude e riacutizza le criticità già insite nella prova scientifi ca.
Al fi ne di colmare tali lacune normative, l’alternativa che si prospetta è quella
del ricorso alla prova atipica (152) avverso l’estensione delle previsioni esistenti, nel
caso in cui non si riesca ad evitare di risolvere la questione facendo riferimento ad
un esito probatorio della responsabilità deducibile da altri elementi di prova. Deve
riconoscersi, infatti, che il ricorso a una ricostruzione che riconduce gli strumenti di
accertamento all’interno della disciplina codicistica delle prove, appare quella privi-
legiata dalla giurisprudenza più recente.
La riferita facoltà di accertamento delle indagini consente quasi sempre di indivi-
duare, nelle condizioni che legittimano l’attività della singola prova, spesso aperta a
orizzonti di estrema latitudine, l’aggancio per legittimare il ricorso ai nuovi strumenti
investigativi. Peraltro, il riferimento alle prove codifi cate trova nella loro disciplina il
terreno ricostruttivo della giurisprudenza ritenuto idoneo ad assicurare le garanzie
dell’accertamento, anche se l’incasellamento nell’una o nell’altra prova può avere
conseguenze e/o rifl essi non secondari. Ne sono in parte esempio le dicotomie:
documentazione o corrispondenza; perquisizione o intercettazione; accertamenti o
rilievi; ispezioni o ricognizioni? Non occorrono molte parole per evidenziare come
dietro le riferite indicazioni siano sottese situazioni molto diverse tra loro sotto vari
profi li: poteri d’urgenza; attività della PG autonoma o delegata; garanzie giurisdi-
zionali; tutele difensive; utilizzi diff erenziati in caso di ripetibilità ovvero di non ri-
petibilità, solo per citare alcune delle connotazioni più signifi cative. Del resto, il già
esposto ambito nel quale collocare la c.d. prova innominata e le riferite situazioni
(151) Torre, Aspetti giuridici e tecnici relativi al trattamento della prova digitale nel processo penale. La
prova informatica nella legge 18.3.2008, n. 48, in Informatica e Diritto, cit., p. 66, la crisi dell’equa-
zione tra scienza e episteme si deve al pensiero di K. R. Popper, che segna defi nitivamente il de-
clino del verifi cazionismo come metodo gnoseologico. Alla fi losofi a popperiana si deve la ormai
acquisita consapevolezza di una scienza come sapere non più indebitamente certo, ma limitato,
incompleto e fallibile.
(152) Tonini, Diritto processuale penale. Manuale breve, Milano, 2011, p. 180, nel capitolo dedicato ai
mezzi di prova tipici e atipici aff erma che secondo l’art. 189 CPP la prova atipica può essere assun-
ta se ha due requisiti: deve essere idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti, cioè deve essere
in grado di fornire elementi attendibili e credibili; deve assicurare la libertà morale della persona
fonte di prova, cioè lasciare integra la libertà di autodeterminarsi (non si può usare la narcolessia o
la cd. macchina della verità).
92